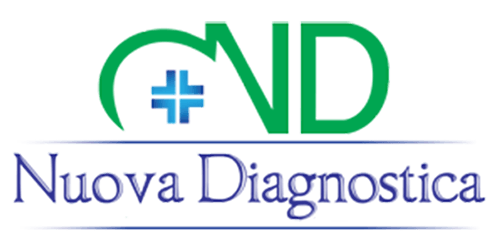Preparazione agli esami
Per effettuare alcuni esami è necessario seguire una scrupolosa preparazione per garantire la buona riuscita dell’esame stesso. Consulta l’elenco qui di seguito per avere informazioni dettagliate e prepararti correttamente.
Per tutti gli altri esami basterà attuare semplici accorgimenti: indossa un abbigliamento comodo; rimuovi eventuali oggetti metallici come collanine, bracciali, orologi, che potrebbero creare artefatti nelle immagini; se hai già effettuato esami nello stesso distretto da analizzare porta con te il referto e le immagini in modo da poterli confrontare con la nuova indagine.
Risonanza Magnetica
CHE COS’È?
La Risonanza Magnetica (in breve RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La diagnostica mediante RM utilizza campi statici di induzione magnetica e onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF), simili alle onde radiotelevisive. Si configura come un esame diagnostico non invasivo e non comporta effetti biologici rilevanti su pazienti privi di controindicazioni.
Approfondimenti
E' un esame che fornisce immagini dettagliate del corpo umano utilizzando un campo magnetico e onde a radiofrequenze. E' diversa dalla TAC perché non usa raggi X. Si basa sulla capacità di captare i segnali emessi dagli atomi di idrogeno - che compongono l'acqua e sono quindi presenti in abbondanza nei tessuti del corpo - quando questi sono sottoposti a un campo magnetico.
Come funziona
Un campo magnetico prodotto da una grossa elettrocalamita agisce sui nuclei degli atomi di idrogeno, che allineano il proprio momento magnetico parallelamente alla linea di forza del magnete, come succede alla limatura di ferro quando è sottoposta ad una calamita. Gli impulsi delle onde a radiofrequenza modificano l'orientamento dei nuclei che, al cessare degli impulsi tornano a orientarsi secondo l'asse del campo magnetico. Così facendo risuonano, cioè emettono un debolissimo segnale detto segnale di risonanza. Captato da ricevitori radio, convertito in impulsi digitali ed elaborato al computer permette di ottenere un'immagine la cui scala dei grigi corrisponde alle diverse intensità del segnale di risonanza. La forza del campo magnetico si misura in tesla ed è indicativa della risoluzione delle immagini, che aumenta man mano che aumenta l'intensità del campo. Solitamente il campo magnetico usato è di 0,5, 1,5 o 3 tesla.
Con la risonanza magnetica si possono fare sezioni su piani differenti del corpo: frontale, sagittale (lungo il piano ideale passante per l'asse longitudinale del corpo, che divide l'organismo in due metà, destra e sinistra) e trasversale (perpendicolare). Mediante l'impiego di mezzi di contrasto, per esempio derivati del gadolinio, è possibile mettere in luce le alterazioni della barriera ematoencefalica (glossario). La barriera ematoencefalica è un sistema paragonabile a un filtro che limita il passaggio di cellule e molecole dal sangue al sistema nervoso centrale, vale a dire all'ambiente nel quale si trovano cervello, cervelletto e midollo spinale.
Il macchinario di risonanza magnetica più usato ha la struttura di un cilindro lungo 1,5 metri e largo 60 o 70 cm di diametro a seconda delle apparecchiature. È aperto alle due estremità, c'è luce e aria. Nel cilindro viene fatto scorrere un lettino su cui è sdraiata la persona. Esistono anche macchinari aperti.
La risonanza magnetica aperta
Rispetto alle risonanze magnetiche chiuse, questo tipo di macchinario è aperto ai lati. Per questo può diminuire il senso di claustrofobia, paura e ansia nelle persone che ne soffrono, o essere utile per le persone in sovrappeso che sono scomode nel fare la risonanza magnetica chiusa. Per alcuni tipi di immagini può avere una qualità di risoluzione inferiore alla risonanza magnetica chiusa.
Cosa è il mezzo di contrasto
In genere per la diagnosi la risonanza magnetica viene fatta con il mezzo di contrasto a base di gadolinio. L'uso del gadolinio nel corso del monitoraggio è variabile da ospedale e ospedale.
Il gadolinio è un metallo raro che si estrae dalla terra. Poiché è altamente tossico, viene disciolto in una soluzione acquosa e legato con altre molecole a una struttura complessa chiamata chelato (il gadolinio è circondato a tenaglia dalle altre molecole, come se fosse stretto tra le chele di un granchio) per ridurne il livello di tossicità. La soluzione viene iniettata con iniezione seguita da piccolo bolo di soluzione fisiologica o con iniezione diretta o con iniettore. L'esame ha due fasi: una prima del contrasto e una dopo che il contrasto è stato iniettato.
Esistono diversi mezzi di contrasto a base di gadolinio. Sono classificati in lineari o macrociclici a seconda della struttura chimica del complesso chelante legato al gadolinio.
Preparazione esame
in lavorazione
TAC
CHE COS’È?
La TC (Tomografia computerizzata) è una tecnica diagnostica che utilizza radiazioni ionizzanti e fornisce, rispetto alla radiologia tradizionale, un miglior dettaglio morfologico di tutte le struttura anatomiche. L’acronimo TAC, con cui spesso viene definita, sta per tomografia “assiale” computerizzata, poiché prima l’esame era condotto lungo un solo asse, con sezioni perpendicolari alla lunghezza del corpo. Oggi esistono macchinari multistrato più moderni e la tomografia computerizzata non è più solo assiale, ma le immagini sono acquisite con una tecnica spirale che permette di ottenere immagini tridimensionali. Pertanto il termine TAC è da ritenersi obsoleto.
Approfondimenti
La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), oggi definita semplicemente TC (Tomografia Computerizzata), é una metodica radiologica che, utilizzando radiazioni di tipo X (esattamente come quelle delle semplici radiografie), é in grado di ricostruire grazie delle sezioni del corppo anche al di sotto del millimetro, grazie all’utilizzo di programmi informatici particolari.
Per effettuare l’esame il paziente viene sdraiato su di un lettino che fa parte dell’apparecchiatura.
A cosa serve l’esame?
La TAC é una metodica di secondo livello generalmente indicata dopo l’esecuzione di esami radiografici o ecografici o in seguito a visite specialistiche.
È molto usata nella ricerca di neoplasie primitive o di localizzazioni secondarie. Trova anche un importante utilizzo nello studio del sistema nervoso centrale (soprattutto l’encefalo) e del sistema vascolare (soprattutto per lo studio delle arterie).
Oltre ai campi tradizionali di impiego (neurologico, scheletrico, traumatologico, toracico, addominale, oncologico, ginecologico, vascolare), la TAC é indicata anche per lo studio dell’apparato urinario (Uro TAC), del grosso intestino (Colon TAC virtuale), delle arterie coronarie (Cardio TAC).
È, infine, molto utilizzata anche nell’urgenza in seguito ad emorragie ed ischemie cerebrali, aneurismi toracici e addominali, embolie polmonari, traumi di vario genere.
Domande Frequenti (F.A.Q.)
Soffro di claustrofobia: riuscirò a fare l’esame TAC?
Il gantry dell’apparecchiatura (quello che comunemente é chiamato “tunnel”) é molto corto e largo. Per tale motivo tutte le persone, anche quelle claustrofobiche, riescono a sottoporsi all’esame TAC senza problemi.
Per eseguire una TAC senza mezzo di contrasto devo rimanere a digiuno?
No, se l’esame non prevede la somministrazione del mezzo di contrasto, non è necessaria alcun tipo di preparazione.
Prima della TAC ho eseguito una radiografia o un’ecografia: le devo portare?
Sì, occorre sempre portare gli esami precedenti. Questo consente al tecnico radiologo di eseguire l’esame in modo idoneo e al radiologo di refertarlo correttamente.
É vero che la dose di radiazioni in TAC è alta?
Per effettuare studi TAC si utilizzano dosi di radiazioni superiori rispetto a quelle di una normale radiografia (anche 40-50 volte superiore).
Per tale motivo é importante che l’esame sia giustificato ed abbia un corretto quesito clinico.
Il nostro personale é correttamente formato al fine di eseguire esami di alta qualità con la minor dose possibile al paziente. La nostra apparecchiatura TAC, inoltre, possiede dei moderni filtri di ricostruzione delle immagini che consentono un abbattimento della dose fino al 50% rispetto ad apparecchiature che ne sono sprovviste.
Si ricorda, comunque, che le dosi di radiazioni utilizzate in radiologia sono sostanzialmente inferiori a quella dose che si è certi possa dare un danno al paziente.
Dopo l’esame mi verrà subito comunicato l’esito?
L’esame TAC prevede l’acquisizione di moltissime immagini che spesso necessitano di ulteriori ricostruzioni prima di poter essere interpretate. Il radiologo, quindi, ha necessità di avere a disposizione tutto l’esame e diverso tempo per poter effettuare una lettura corretta.
Per tale motivo difficilmente si avranno notizie immediate dopo l’esecuzione dell’esame.
Preparazione esame
in lavorazione
Ecografia
CHE COS’È ?
L’Esame Ecografico (in breve esame ECO) è un’indagine che utilizza onde ultrasonore per studiare le diverse strutture anatomiche (organi addominali, parenchimi, parti molli superficiali, articolazioni, ecc).
Approfondimenti
L’ecografia è una metodica diagnostica non invasiva che utilizzando ultrasuoni (onde sonore) emessi da particolari sonde appoggiate sulla pelle del paziente, consente di visualizzare organi, ghiandole, casi sanguigni, strutture sottocutanee ed anche strutture muscolari e tendinee in numerose parti del corpo.
Durante l’esecuzione dell’ecografia, l’area da esaminare viene inumidita con un apposito gel, non tossico, che consente una migliore trasmissione degli ultrasuoni attraverso il corpo umano.
A cosa serve l’ecografia?
L’ecografia costituisce uno dei primi approcci allo studio del corpo umano, fatta eccezione della parte scheletrica e delle strutture interne alla scatola cranica. Gli ultrasuoni, infatti, non sono in grado di studiare le strutture ossee.
Le ecografie sono, invece, molto utilizzate per lo studio del collo (tiroide, linfonodi), dell’addome (fegato, reni, milza, pancreas, eccetera), della pelvi (vescica, utero, ovaie, prostata), delle vene e delle arterie (carotidi, aorta, eccetera), dell’apparato muscolare (muscoli, tendini, legamenti).
Domande Frequenti (F.A.Q.)
L’ecografia é un’indagine pericolosa per i bambini e le donne gravide?
No, l’ecografia non prevede emissione di radiazione di tipo X. Può essere, pertanto, effettuata con una certa frequenza qualora si rilevi la necessità di eseguire ripetute indagini in presenza di patologie note a scopo di monitoraggio.
É richiesta una particolare preparazione per effettuare l’ecografia?
Dipende dal tipo di ecografia. Non richiedono preparazione ad esempio l’ecografia del collo, dei muscoli, delle articolazioni, mentre è necessaria la preparazione per lo studio dell’addome e della pelvi. Nel nostro sito è possibile trovare, accanto ad ogni esame, le norme di preparazione.
Sono utili le indagini precedenti o le cartelle cliniche indicanti interventi chirurgici o farmaci assunti?
Sì, è importante portare sempre con sé indagini precedenti anche diverse dall’ecografia, referti di visite specialistiche o cartelle indicanti interventi chirurgici effettuati. E’ importante anche indicare i farmaci assunti.
Preparazione esame
in lavorazione
MAMMOGRAFIA
CHE COS’È?
La mammografia è un’indagine che utilizza radiazioni ionizzanti (raggi x), a basso dosaggio, per la diagnosi della patologia mammaria. Alla tradizionale mammografia oggi si aggiunge la mammografia integrata con tomosintesi e acquisizione 3D, tecnica di imaging tridimensionale che consente di ricostruire immagini volumetriche della mammella a partire da un numero finito di proiezioni bidimensionali a bassa dose, ottenute con angolazioni diverse grazie al movimento del tubo radiogeno che ruota attorno al seno della paziente. Estremamente efficace, questo nuovo strumento diagnostico è in grado di rilevare con una significativa accuratezza lesioni tumorali al seno anche di dimensioni assai ridotte, con un’efficacia doppia rispetto alla consueta mammografia tradizionale, soprattutto nei seni densi. Nel nostro centro pertanto abbiamo deciso di effettuare direttamente la tomosintesi a tutte le pazienti utilizzando un macchinario che eroga minore quantitativo di radiazioni possibili e che permette così di evidenziare i primi segni di neoplasia, prima ancora che si identifichino nella mammografia tradizionale.
Approfondimenti
La mammografia è un esame fondamentale per la prevenzione del tumore della mammella.
Mediante l’impiego di radiazioni ionizzanti essa consente lo studio morfologico della mammella ed è in grado di rilevare la presenza di lesioni mammarie tra cui quelle di origine tumorale che si presentano sotto forma di opacità nodulari a margini irregolari, micro-calcificazioni polimorfe, oppure aree di distorsione strutturale.
Questo esame diagnostico ha subìto un’importante evoluzione nel corso degli ultimi vent’anni nel corso dei quali si è passati dalla mammografia analogica a quella digitale ed infine alla mammografia in Tomosintesi, quest’ultima sempre più diffusa e in grado di aumentare la capacità diagnostica rispetto alle metodiche precedenti. A differenza della mammografia “tradizionale”, la Tomosintesi consente infatti una valutazione più accurata della mammella scomponendone lo spessore in multipli strati: tramite questo accorgimento è possibile diagnosticare quelle lesioni che, a causa del mascheramento dovuto alla sovrapposizione del tessuto ghiandolare, talora possono essere misconosciute specie nei seni caratterizzati da un’elevata densità fibro-ghiandolare.
La Tomosintesi aumenta dunque sia la sensibilità – ovvero la capacità di riconoscere i tumori – sia la specificità – ovvero la capacità di negativizzare i reperti falsi positivi.
La dose radiogena impiegata nell’eseguire una mammografia, anche nella modalità in Tomosintesi, è estremamente bassa e innocua.
A cosa serve la mammografia?
La mammografia è un esame fondamentale per la prevenzione del tumore della mammella poiché è in grado di individuare anche lesioni di piccole dimensioni.
L’esecuzione della mammografia è indicata, a prescindere dalla presenza di sintomi o di casi in famiglia, dall’età di 40 anni e ciò in funzione del progressivo aumento, da quest’età, dell’incidenza del tumore mammario.
La cadenza dei successivi controlli dipenderà dalla valutazione del Radiologo e dal grado di densità fibro-ghiandolare che è variabile da soggetto a soggetto. Nei seni particolarmente densi l’intervallo ottimale tra una mammografia e la successiva è annuale; numerosi studi scientifici hanno infatti dimostrato che, in questa tipologia di seno, è efficace ridurre l’intervallo temporale tra una mammografia e l’altra. Tale intervallo, in ogni caso, non deve mai essere inferiore ai dodici mesi per motivi di radio-protezione. In questa tipologia di seno, poiché la radiopacità indotta dal tessuto ghiandolare fa sì che una lesione non sia individuata, può essere indicato il completamento diagnostico mediante l’ecografia mammaria.
Nelle donne che, invece, hanno una mammella poco densa o in quelle che non hanno familiarità per tumore mammario, è indicato l’impiego della sola mammografia con un intervallo tra i due test che, in assenza di familiarità, può raggiungere anche i due anni.
È necessaria una preparazione prima dell’esame?
Per consultare eventuali norme di preparazione all’esame, è possibile visitare la pagina dedicata (cliccando qui).
Chi può effettuare l’esame?
Chiunque, sebbene sia indicato come esame di prevenzione dall’età di 40 anni.
La diagnosi precoce di un tumore è l’obiettivo del controllo mammografico in assenza di sintomi: è infatti dimostrato che la maggior parte dei carcinomi mammari diagnosticati in fase preclinica si risolve positivamente. Quando, invece, la scoperta avviene in una fase più avanzata, le possibilità di trattamento e guarigione sono molto più limitate.
Ne consegue che, tutte le donne che abbiano superato i 40 anni, età dalla quale l’incidenza del tumore mammario comincia a essere più rilevante, dovrebbero sottoporsi a una mammografia.
L’esame viene prescritto alle donne sotto i 40 anni soltanto in pochi casi selezionati soprattutto per evitare di sottoporle ad un numero eccessivo di mammografie nel corso della vita. In questa fascia di età, in rapporto all’incidenza molto bassa del tumore al seno, non vi è indicazione all’esecuzione di alcuna forma di screening: in presenza di una importante familiarità (più casi di tumore mammario in familiari di primo e/o secondo grado) è tutt’al più consigliabile l’esecuzione dell’ecografia mammaria a partire dai 30 anni.
Non c’è un limite di età per l’esecuzione della mammografia: finchè lo stato di salute lo consente è suggerito il controllo mammografico anche oltre i 70 anni.
È un esame doloroso o pericoloso?
La mammografia non è solitamente un esame doloroso e si esegue, di norma, senza l’ausilio di anestesie o sedazioni. La bassa dose di radiazioni ionizzanti cui la paziente è esposta rende il beneficio diagnostico molto superiore ai possibili effetti secondari.
Come funziona?
L’esame dura pochi minuti e viene eseguito con un particolare strumento radiologico chiamato mammografo in grado di proiettare un fascio di raggi X direttamente sulla mammella e di fornirne una valutazione morfologica e strutturale.
La tecnica di esecuzione prevede il posizionamento della mammella su di un apposito piano (detettore) e la successiva compressione su di esso tramite una piastra di plastica (compressore): tale compressione, che dura pochi secondi, garantisce l’immobilità della mammella durante l’acquisizione radiografica, indispensabile per ottenere un’immagine di qualità. La compressione della mammella consente inoltre di utilizzare dosi di radiazione più basse in quanto, riducendo lo spessore della mammella, si riduce la dose da erogare. L’esame mammografico standard prevede per ogni mammella l’acquisizione di due proiezioni, una cranio-caudale e una obliqua medio-laterale: in questo modo è garantita la visualizzazione completa dell’organo.
La disponibilità di un confronto con eventuali mammografie eseguite precedentemente aumenta l’accuratezza diagnostica in quanto consente di identificare facilmente eventuali variazioni. Allo stesso tempo la stabilità nel tempo di un reperto orienta per la sua benignità e consente di escludere elementi di sospetto.
Preparazione esame
in lavorazione
MOC
CHE COS’È?
La MOC – Mineralometria Ossea Computerizzata – è una tecnica diagnostica radiografica non invasiva densitometria, che misura il Contenuto Minerale Osseo (Bone Mineral Content o BMC) e la Densità Minerale Ossea (Bone Mineral Density o BMD) del segmento osseo in esame.
Approfondimenti
La MOC, ossia la Mineralometria Ossea Computerizzata, è un esame di cui ci si avvale per valutare lo stato di salute delle ossa. Serve a determinare se la densità minerale si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela dunque utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea, poiché consente di identificare la malattia in fase precoce. Ne abbiamo parlato con il Professor Gherardo Mazziotti, Capo Sezione Ricerca, Diagnosi e Cura delle Malattie Osteometaboliche in Humanitas
Che cos’è la MOC?
La MOC è una densitometria, che misura la densità minerale ossea dello scheletro, dunque la massa e la quantità di minerali in esso presenti. Si tratta di un esame consigliato in particolar modo alle donne in post-menopausa e agli uomini over 60 con accertati fattori di rischio per lo sviluppo di osteoporosi. La MOC viene anche prescritta a individui di qualunque età e genere in caso di sospetto di osteoporosi geneticamente determinata, osteoporosi secondaria a malattie croniche e a terapie croniche potenzialmente osteopenizzanti.
La MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) si esegue mediante la DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry), tecnica a doppio raggio X.
La MOC-DEXA misura la densità minerale nelle ossa di una zona campione, ossia un’area ben delimitata dello scheletro. Queste zone sono solitamente la colonna vertebrale e il femore prossimale. Lo strumento procede in modo automatico, indicando la Bone Mineral Density (BMD), ossia la densità minerale in grammi per centimetro quadrato.
La BMD viene espressa quantitativamente mediante due parametri, il T-score e lo Z-score.
Il T-score misura la differenza tra il valore di BMD dell’osso esaminato e il campione di riferimento, rappresentato da soggetti sani di 30 anni esaminati nel momento in cui si raggiunge il massimo livello di massa ossea L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che un T-score superiore a -1 deviazioni standard corrisponde a una situazione di normalità; un T-score compreso tra a -1 e -2.5 deviazioni standard indica un’osteopenia, dunque un modesto impoverimento dell’osso; mentre un T-score inferiore a -2.5 deviazioni standard indica la presenza di osteoporosi, che implica un rischio sensibilmente maggiore di andare incontro a fratture. Il T-score viene utilizzato per definire il rischio fratturativo in soggetti di età superiore ai 50 e donne in post-menopausa.
Lo Z-score misura la differenza tra il valore di BMD dell’osso esaminato e il campione di riferimento, rappresentato da soggetti sani e di pari età. Tale parametro viene utilizzato per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e nelle donne in pre-menopausa; in questi casi, il valore di riferimento dello Z-score per definire una condizione di fragilità scheletrica è -2.0 deviazioni standard.
Come si svolge la MOC
La MOC non necessita di alcuna preparazione specifica e dura pochissimo, circa tre minuti: il paziente viene fatto sdraiare su un lettino dove lo strumento di emissione dei raggi X, situato sotto il materassino, è accoppiato a un braccio mobile che contiene il rilevatore dei raggi e che scorre lungo i segmenti scheletrici analizzati.
In seguito lo specialista stabilità un calendario di monitoraggio (abitualmente ogni 18-24 mesi) per monitorare eventuali cambiamenti nella densità minerale ossea e prevedere gli eventi fratturativi, nonché per valutare l’efficacia dei trattamenti anti-osteoporotici in atti.
Preparazione esame
in lavorazione
Prenotate con serenità i vostri esami diagnostici. Contattate il Centro Nuova Diagnostica di Catania.
Viale XX Settembre, 52/A - 95128 Catania (CT)
Via Battista Grassi, 3 - 95128 Catania (CT)
Telefono
Cellulare
P.I. 04509080877 | Informazioni Legali | Privacy Policy e Cookie Policy